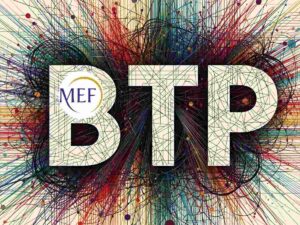Il concordato preventivo biennale introdotto dal Dlgs 13/2024 assicura stabilità fiscale per imprese e professionisti, ma resta un dubbio centrale: nel rinnovo 2026-2027 si prenderà come base il reddito concordato del 2025 o il reddito effettivo prodotto nello stesso anno?
Il tema del concordato preventivo biennale (Cpb) ha attirato grande attenzione perché consente ai contribuenti di ottenere una certezza sulle imposte dovute per due anni, in cambio di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. La novità ha trovato applicazione per il biennio 2024-2025, con l’opzione di un successivo rinnovo per il 2026-2027. Tuttavia, l’articolo 14 del Dlgs 13/2024 non chiarisce se la nuova proposta dell’Amministrazione finanziaria verrà formulata partendo dal reddito concordato nel 2025 oppure da quello effettivamente dichiarato nello stesso anno. Una differenza non marginale: basti pensare al caso di un contribuente che abbia concordato un reddito di 50.000 € ma chiuso l’anno con 40.000 €. La base di partenza potrebbe cambiare in modo significativo il carico fiscale futuro.

Secondo la Relazione illustrativa al decreto e gli approfondimenti pubblicati da Il Sole 24 Ore, la logica del Cpb punta a garantire continuità e stabilità, ma senza escludere la possibilità di correttivi in presenza di scostamenti molto rilevanti. In questo scenario, anche il ruolo degli ISA (indici sintetici di affidabilità) diventa centrale, perché gli incrementi per il rinnovo si calcolano sulla base del punteggio di affidabilità fiscale.
Reddito concordato o reddito effettivo: quale base per il rinnovo?
L’articolo 14 del Dlgs 13/2024 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate formuli al contribuente una proposta di rinnovo del concordato preventivo biennale. Tuttavia, la norma non specifica espressamente quale reddito utilizzare come riferimento. Le interpretazioni più accreditate indicano che il reddito da assumere sia quello concordato per il 2025, sul quale applicare gli adeguamenti previsti dagli ISA. Questa impostazione è coerente con la logica del Cpb, che nasce per offrire certezza e stabilità, riducendo l’impatto delle fluttuazioni economiche annuali.

Se invece si considerasse il reddito effettivo, l’istituto perderebbe parte della sua funzione pattizia, trasformandosi in un meccanismo più simile a una normale dichiarazione dei redditi. Alcuni tributaristi segnalano che solo in presenza di scostamenti macroscopici potrebbe essere valutata l’introduzione di correttivi, ma ciò richiederà chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione.
Implicazioni pratiche, ruolo degli ISA ed esempi numerici
Sul piano operativo, le conseguenze della scelta sono molto concrete. Un contribuente che abbia concordato 50.000 € per il 2025 ma chiuso l’anno con un reddito effettivo di 40.000 € si troverebbe, in caso di rinnovo basato sul concordato, a partire da 50.000 € come nuova base imponibile per il 2026-2027. Questa cifra sarebbe poi adeguata in funzione del punteggio ISA, che può ridurre o aumentare l’incremento richiesto. Se invece si partisse dal reddito effettivo di 40.000 €, la base sarebbe più bassa, ma si rischierebbe di compromettere la certezza dell’accordo.
Al contrario, se il reddito effettivo fosse superiore (ad esempio 60.000 € a fronte di 50.000 € concordati), un ancoraggio al dato concordato risulterebbe più favorevole per il contribuente. Gli esperti segnalano che, fino a quando non ci saranno chiarimenti ufficiali da parte del MEF o dell’Agenzia delle Entrate, la linea più coerente con la ratio dell’istituto resta quella di prendere a riferimento il reddito concordato, modulato dagli ISA, e non quello effettivo.