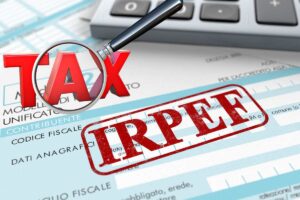Dal 2026 la pensione di vecchiaia potrebbe trasformarsi in un passaggio cruciale per il sistema previdenziale italiano. L’idea di eliminare l’assegno sociale, sostituendolo con regole uniformi per tutti, sta accendendo il dibattito politico e sociale. Le conseguenze non riguarderebbero solo la burocrazia, ma milioni di persone che oggi si trovano ai margini delle tutele.
Un cambiamento di questo tipo non è una semplice modifica normativa, ma un vero spartiacque tra vecchie e nuove generazioni di lavoratori. La questione tocca chi si trova a metà strada, con carriere discontinue o contributi frammentati, che fino a oggi hanno rischiato di vedere svanire parte dei propri versamenti. In gioco c’è il futuro di chi, dopo una vita di lavoro, si ritrova senza la certezza di un trattamento pensionistico.

È proprio in questa prospettiva che il 2026 appare come una data di confine, un orizzonte che divide il prima e il dopo nella storia della previdenza.
Verso l’armonizzazione delle regole pensionistiche
Oggi le differenze tra le categorie di lavoratori sono marcate. Chi ha iniziato a versare contributi prima del 1996 può andare in pensione a 67 anni con almeno 20 anni di versamenti. Chi invece rientra nel cosiddetto contributivo puro ha percorsi differenti: pensione a 64 anni con 20 anni di contribuzione, ma solo se l’importo maturato è pari ad almeno tre volte l’assegno sociale, oppure pensione a 71 anni con un minimo di 5 anni di versamenti. È su queste disparità che si concentra la discussione politica: se venissero superate, il sistema diventerebbe più semplice e uniforme.

Le ipotesi più recenti prevedono una pensione di vecchiaia aperta a tutti i lavoratori a 71 anni, anche con soli 5 anni di contributi. Questo significherebbe cancellare, per chi ha versato almeno qualcosa, la necessità di ricorrere all’assegno sociale, misura che oggi rappresenta l’unica alternativa per chi non ha i requisiti minimi per la pensione ordinaria.
Un esempio concreto rende l’idea. Un lavoratore con contributi “misti”, cioè una parte prima e una parte dopo il 1996, che non raggiunge i 20 anni a 67 anni, oggi si trova costretto a chiedere l’assegno sociale. Con il nuovo scenario, potrebbe attendere i 71 anni ed entrare comunque nel sistema previdenziale con i suoi contributi, evitando di dipendere da una prestazione assistenziale.
Equità previdenziale e scenari concreti
Il tema tocca da vicino la vita di migliaia di persone. Pensiamo a un’insegnante con una carriera discontinua, che ha alternato anni di lavoro stabile a lunghi periodi di precariato. Oggi rischia di rimanere esclusa da una pensione dignitosa, pur avendo versato contributi per oltre un decennio. Con le nuove regole, a 71 anni avrebbe la possibilità di ricevere una pensione di vecchiaia senza dover contare sull’assegno sociale, che rimarrebbe invece destinato a chi non ha versato nulla o vive in condizioni di povertà estrema.
Il nodo centrale è quello dell’equità. La Corte Costituzionale negli ultimi anni ha già richiamato il legislatore sulla necessità di eliminare trattamenti discriminatori, come nel caso degli invalidi contributivi puri, penalizzati rispetto a chi aveva iniziato a versare prima del 1995. L’armonizzazione delle regole si inserirebbe in questa scia, ponendo fine a distinzioni che appaiono sempre più difficili da giustificare.
Guardando avanti, il 2026 potrebbe segnare non solo la fine dell’assegno sociale come via obbligata, ma anche l’inizio di un sistema più coerente. Resta però aperta una riflessione: quale sarà l’impatto reale sulle future generazioni, che già oggi si trovano a fare i conti con carriere instabili e stipendi bassi? L’idea di una pensione universale a 71 anni potrebbe garantire maggiore inclusione, ma resta da capire se sarà sufficiente a restituire fiducia a un sistema che, da anni, appare in bilico tra sostenibilità e giustizia sociale.